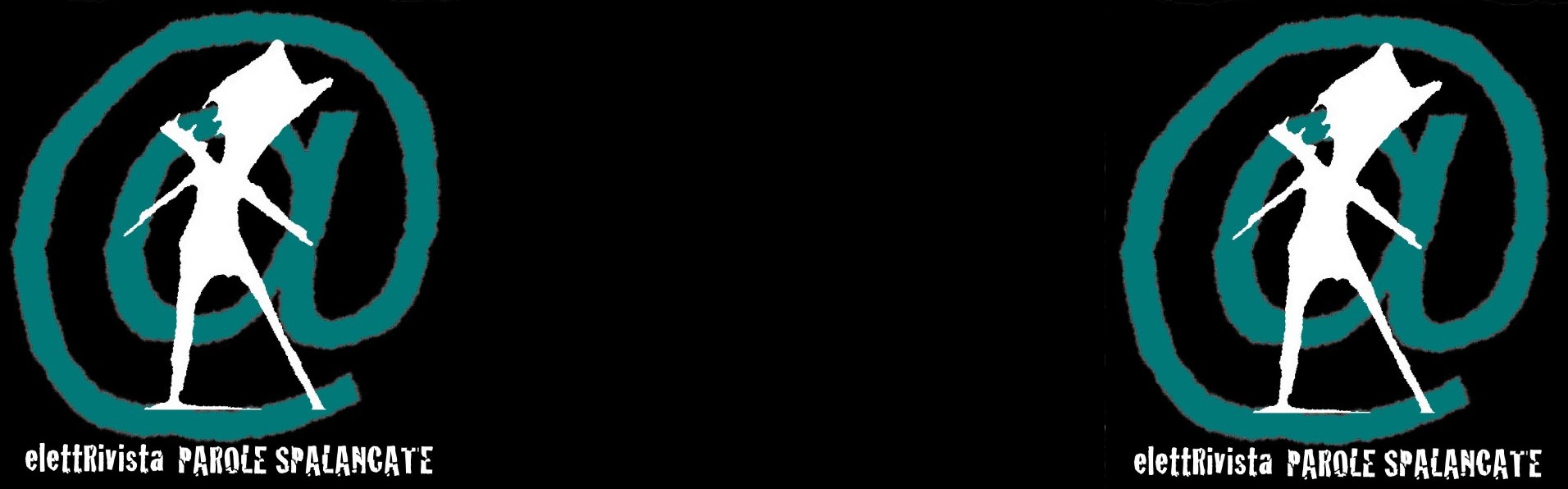11 Mag Classici contemporanei
CLASSICI CONTEMPORANEI
Rubrica di Marco Ercolani*
ALESSANDRO RICCI
Tutte le poesie
(Europa Edizioni, 2019
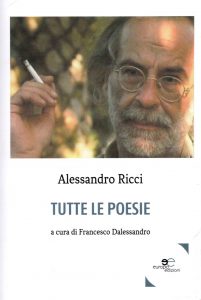 «Si può rimetterci
«Si può rimetterci
anche la pelle.
Ma cominciarono.
Sull’incisione
greca
dell’anima, sulle
divinità rimaste».
L’avventura poetica di Alessandro Ricci (1943-2004) si articola in cinque raccolte: Le segnalazioni mediante i fuochi (Piovan, 1985), Indagini sul crollo (Edizioni del Leone, 1989), pubblicate in vita, a cui segue, dopo un silenzio di quindici anni, I cavalli del nemico (Il Labirinto, 2004), uscito due mesi dopo la morte. Postumi, grazie alle cure di Francesco Dalessandro, appaiono L’arpa romana e L’editto finale. Le edizioni Coup d’idée pubblicano nel 2015 un’antologia poetica di Ricci, con postfazione di Stefano Agosti. Francesco Dalessandro cura, nel 2019, Tutte le poesie per Europa Edizioni.
Di se stesso dice il poeta, in una nota alla prima raccolta postuma: «Non scrivo più non dico versi, ma neppure cartoline: per una sorta di vergogna degli anni che passano, di una deriva irrilevante del pensiero, della fantasia, della disciplina ottenebrati da una depressione sorda, senza memoria, banale come un mal di testa continuo… In molti dei miei sogni agitati, incubi o allucinazioni, parto da un oggi spietato e scendo scalinate e paesaggi concentrici, a ritroso nel tempo, fino a incontrare i miei “eroi” nel momento della loro resa più incondizionata».
Chi sono gli eroi di Ricci?
Guido Cavalcanti, Giuliano l’apostata, Gaio Valerio Catullo, l’ufficiale di Serse. Tutti sosia fraterni che fanno sentire l‘autore meno solo e superfluo.
Le poesie di Ricci appaiono come epigrafi tristi, arcaiche, dove la voce è sempre quella di un eroe giunto alla fine dei suoi progetti e delle sue speranze. Rispetto alla potenza malinconica della Yourcenar nelle Memorie di Adriano, siamo dentro un microcosmo simile a quello, ma dove serpeggia, nell’architettura dei versi, un senso di apatia, di inconclusione, di “morte all’opera”.
La lingua del poeta è un miracolo di sobria ingegneria verbale: arcaica e dispersa insieme, si insegue e si ritrova per traiettorie oblique. Voce apocrifa che nasconde l’autore o meglio lo rivela nella nudità desolata del pensiero, oppure voce di un io remoto che ritorna all’infanzia, agli studi antichi.
Ricci ripudia ogni forma di attualità.
Crea paesaggi concentrici, a ritroso nel tempo, come se volesse ritrovare solo nel passato i suoi affini. C’è, nella sua poesia, una resa malinconica, un abbandonarsi al destino della sconfitta: lo testimoniano le sue poesie, affilate come lapidi, come segni remoti. La voce di Ricci si articola attorno ai temi che hanno sempre costituito l’oggetto della sua ricerca: il doloroso assillo per un’epoca persa (la classicità greco-romana) che nessuna espressione poetica può riportare in vita; e una domanda amorosa che mai ottiene risposta.
Così scrive della lingua di Ricci il curatore Francesco Dalessandro: «Una lingua che è colta, ricca, dal valore classico, ma anche aspra, tuttavia duttile, capace di rinvigorire e talvolta far rinascere termini dotti e arcaici, come di accogliere in sé la parola degradata e un parlato più umile, tutto nobilitando con il ritmo e con il lucido articolarsi del pensiero».
L’architettura delle sue poesie è affidata a strofe che sfilano una nell’altra con enjambements non tradizionali, realizzando una partitura metrica che ora si contrae e ora si espande, come a rappresentare un respiro fragile e umano, fra crepe e frane, una malinconia che insegue la quiete dell’editto finale.
«L’accese la prima, fu pronta
la seconda sull’altra
torre, e poi la terza
e la quarta e così
via, di torcia
in torcia e di vedetta
in vedetta, fino al’ultimo
uomo
che non rispose».
La lapidaria fermezza della lingua, che vaga attorno a personaggi inattuali in una sorta di identificazione postuma con figure simboliche di utopia o di sconfitta, rende Ricci un isolato, un perdente che non vuole farsi riassorbire da nessuna storia esatta, determinata, e che proprio per questo attira i rabdomanti della poesia “vera”. «Oggi / è il mille / di marzo. Fatti / i calcoli, fatti / i nomi che pesano». Quel mille di marzo è, da sempre, l’orizzonte inattuale della poesia di Alessandro.
«Manovravi sul
fuoco, finché
tornassero alla vista
in segreto le ultime
di esso, e prime
onde dell’altro
emisfero».
In questo breve frammento il mistero è nella versificazione, scabra, che la sottrae a una forma compiuta e la rende felice/infelice frammento, ignaro di sé stesso, copia di chissà quale emozione o dolore. I “tempi forti” del racconto, come ci ricorda Stefano Agosti, subiscono un procedimento di ellissi; molti dettagli vengono focalizzati e accresciuti; viene usato il libero discorso indiretto che attualizza la temporalità storica.
Tutti gli eroi, alter ego del poeta, maschere della sua volontà di sparizione, si interrogano sulle scelte e gli errori, all’interno di un faticoso travaglio interiore. Come osserva Stefano Guglielmin: «Quando per esempio Ricci ci mostra l’imperatore Giuliano passare in rassegna le proprie truppe, “dopo una notte insonne ma non / inquieta”, e lo segue poi in battaglia, colpito dal nemico, e nella tenda fra i generali amici, attraverso strategie retorico-stilistiche e strutturali, sembra parlarci di un uomo vicinissimo a noi, ai nostri tremori e alle nostre preoccupazioni fondamentali». L’io lirico appare del tutto assente. Questa poesia svela come autorevoli personaggi storici, colti nel cuore della loro vita a combattere anche per la sorte di un impero, debbano essere sempre consapevoli di quanto la morte scavi ogni loro azione come un lento, ipnotico veleno.
«Che c’è di vero in tutto questo?
Hanno issato uno specchio
enorme che mi esclude,
privo solo di me, per rispetto
di me? Forse
ho ben meritato
di loro, e temono ch’io guardi
il mio corpo trafitto?
Ma no, sento che l’hanno coperto
di soffice lana, sono
semplicemente cieco»…
Ricci insiste: «nella volta io / non sono dipinto / manco».
È la ricerca di questo mancare che spinge il poeta a ritroso nel tempo, come a ritrovare i “compagni del nulla” che prima di lui erano, come lui, disperati e alla deriva, alla ricerca di un senso che sempre viene meno. Il suo verso, franto da continui enjambements, austero e ipnotico, lo testimonia come una crepa esatta nel marmo, una venatura rigorosa nella perfezione del monumento. «La testa del capitano / è l’ultima cosa della / nave che affonda». Splendida, in La provincia marina di Bisanzio, l’invocazione che Teodoreto il vecchissimo rivolge allo scultore Suida, incapace di fissare nel marmo i volti di Venere e di Adone dopo averne modellato i corpi:
«…E non recare altra
pietra da sovrapporre. Scava quella
che resta, plasma le facce in concavo,
come se altri dall’interno del tempio
o la radice del marmo le vedano
quali le pensi o furono.
Coraggio, Suida. Le
figure cave, pura formula, anime cave,
resistono meglio al tempo».
Affiora, come in un soffio, la necessità di una superficie cava, invisibile all’esterno e visibile solo all’interno: questo è il simbolo segreto di un poeta assetato di immagini remote e “ferito a morte”, la cui opera infelice evoca le atmosfere struggenti di Kavafis e dell’ultimo Yeats, nel suo costante “temperare la punta alla morte”.
«Si costruiscono zattere anche
per non salvarsi, per non
raggiungere approdi ma
perdersi, e lo si fa
intenti, odiandosi quasi
serenamente, sapendo che
Penelope non aspetta
al di là del mare,
e nient’altro
che mare
c’è».
 *Marco Ercolani è psichiatra e scrittore. E’ autore di una vasta bibliografia che comprende saggi, romanzi e raccolte poetiche.
*Marco Ercolani è psichiatra e scrittore. E’ autore di una vasta bibliografia che comprende saggi, romanzi e raccolte poetiche.
Con Turno di guardia ha vinto nel 2010 il Premio Montano per la prosa inedita. Tra le sue ossessioni: i racconti apocrifi, le vite immaginarie, la poesia contemporanea e il nodo arte/follia.